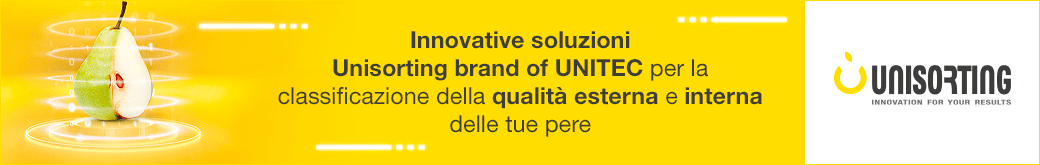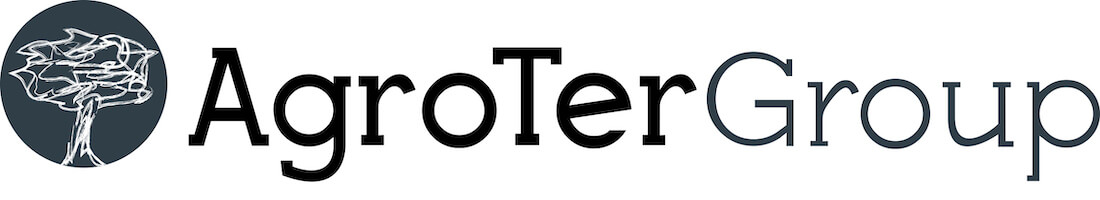Il meglio di IFN
Sulla ricerca ortofrutticola
Il contesto e le prospettive fra pubblico e privato

Ho scritto questo breve contributo per rispondere a una sollecitazione di Roberto Della Casa volta a comprendere “perché l’ortofrutticoltura italiana soffra la mancanza di una ricerca pubblica forte, che guidi i produttori nelle scelte da compiere”.
Prima di tentare di rispondere è doveroso tener presente che la situazione della ricerca sta mutando profondamente, non solo a causa dei noti fattori di crisi economica e di mercato ma anche come conseguenza delle nuove tecnologie, dell’informatica di precisione, del monitoraggio della qualità, ormai dilaganti anche in campo frutticolo.
La “transizione ecologica”, che sta sconvolgendo l’agricoltura, restituisce quindi protagonismo alla frutticoltura, dando per scontato che senza ricerca non si può innovare e senza innovazioni non si può rimanere competitivi sul mercato.
Ma come utilizzare al meglio, senza conflittualità, gli strumenti disponibili, per mantenere alta la produttività aziendale e la qualità dei prodotti, consentire i turnover varietali degli impianti e al tempo stesso rispettare la biodiversità ambientale e genetica, la fertilità del suolo, la sicurezza e sanità della frutta?
Le lamentele di vari soggetti della filiera produttiva, provengono talvolta da settori che godono già di privilegi (es. aiuti PAC) e non sanno rispettare ruolo e dignità di chi fa seriamente ricerca e necessita, dunque, di tempi e mezzi appropriati. Riporto soltanto due esempi eclatanti.
Mezzo secolo fa la meccanizzazione integrale della raccolta, in frutticoltura (salvo olivo e frutta secca) fallì il bersaglio perché non poteva salvaguardare l’integrità del prodotto mentre ne riduceva fortemente la resa. L’automazione della raccolta, a parte la destinazione all’industria di trasformazione, è rimasta un miraggio, perché l’albero non si può adattare totalmente alla macchina. Oggi, “mutatis mutandi”, di fronte agli ormai numerosi modelli di “robotizzazione” della raccolta delle mele, come visti all’ultimo Interpoma, non sarà la perfezione della macchina ma la convenienza economica del suo uso, a deciderne un eventuale impiego e la diffusione.
Un secondo esempio riguarda la sostituzione delle uve da tavola (con semi) con le varietà apirene. Già negli anni ’70, il prof. Olmo dell’Università di California, preconizzò che ci sarebbe stato un futuro solo per le uve apirene. Ma sono occorsi più di 50 anni perché nell’ettarato dei nuovi impianti di vigneti le varietà apirene superassero quelle tradizionali. Nel frattempo, infatti, si sono dovuti attendere i risultati del “breeding” e della sperimentazione di nuove varietà apirene, più produttive e di qualità gustative comparabili a quelle dell’uva Italia e delle altre pregiate varietà ancora oggi diffuse negli impianti tuttora esistenti.

Le attuali tendenze dell’agricoltura mirano a capovolgere il vecchio paradigma della produttività, perseguendo obiettivi apparentemente rivoluzionari, incentivati da misure tese a salvaguardare l’ambiente, ad aumentare il sequestro dell'anidride carbonica e la diminuzione delle inevitabili contaminazioni di acqua, aria, suolo a scapito della salubrità dei frutti.
Comunque stiamo attraversando una “transizione ecologica” non indolore, quali che siano i diversificati indirizzi colturali via via applicati territorialmente da produzioni integrate o biologiche o biodinamiche, a residuo zero, ecc..
Il che significherebbe, oltre alla auto-esclusione da larghe fette di mercato, rendere l’Italia ancor più dipendente da importazioni di ortofrutta da paesi che non dispongono dei severi disciplinari di produzione e dei controlli di sicurezza vigenti in Italia, attestati da marchi, garanzie di processo, e costose certificazioni.
Ciononostante occorre riconoscere all’attuale sistema di ricerca italiana, una netta inversione di tendenza in campo progettuale e di strategie di sviluppo, destinati a dare tangibili risultati già a breve tempo, perché gestiti spesso (o con la partecipazione) di associazioni di produttori e privati cointestatari dei progetti, dei quali cofinanziano l’attuazione e, straordinariamente, dei fondi Pnrr pure in parte destinati alla ricerca, nonché di finanziamenti aggiuntivi nazionali e “regionali”.
La ricerca, perciò, se condotta seriamente nelle strutture istituzionali, non può essere confusa con attività cosiddette sperimentali ed empiriche, condotte da organizzazioni private, magari improvvisate e prive delle necessarie competenze.
Vi sono settori come quello dell’innovazione frutticola, varietale e vivaistica, dove l’Italia tradizionalmente svolge ruoli di primo piano nel mondo, che andrebbero quindi preservati e assecondati. E invece, al contrario, queste attività sono sempre più in mano ad imprese multinazionali, che operano in mancanza di specifiche regolamentazioni, protette dagli scudi brevettuali, e senza che siano sempre tutelati i fruitori dei loro servizi, cioè agricoltori e consumatori.
Persistendo l’attuale e consistente calo dei consumi della frutta, occorre mantenere un elevato standard qualitativo dei prodotti e questo non si può realizzare senza il determinante apporto scientifico-tecnologico, fornito attraverso la ricerca pubblica e privata.
La politica dovrebbe sostenere e guidare le categorie produttive che accettano la sfida, favorendone il peso contrattuale e rendendole meno dipendenti dal sistema distributivo e da una penalizzante logica di filiera.
Porto ancora l’esempio delle mele: la Gdo di fronte a 69 nuove varietà di mele protette da Club censite a Interpoma 2022 e potenzialmente presenti sul mercato, può accoglierne solo una minima parte. Il business, per oltre il 70%, è infatti costituito da sole 5 varietà. Non c’è sufficiente spazio, gli scaffali non bastano per venderne altre, quali che siano qualità, brand, bollini, certificazioni, e per quanto possano essere altrimenti accessoriate. I consumatori danno per scontati questi valori, divenuti ormai normalità.
Privilegiano invece altri valori, per es. sanitari, il benessere fisico e magari sono incuriositi da altre “story-telling attraenti”. Tutto ciò sta a significare che la Gdo - quale controparte per le attente ma quasi disarmate associazioni di produttori - può imporre le proprie scelte e condizionare pesantemente quelle degli agricoltori.
Per concludere grazie al crescente rafforzamento del sistema di ricerca, nazionale ed internazionale, la ortofrutticoltura può affrontare fiduciosamente il futuro sfruttando varie opportunità prima inesistenti. Purtroppo non c’è contemporaneità fra la velocità di acquisizione di macchine, strumenti e soluzioni tecnologiche con i tempi di realizzazione da parte degli agricoltori degli investimenti necessari per rendere fruibili tempestivamente le stesse innovazioni. Una disfasia che indebolisce il sistema produttivo.
Bisogna dunque sperare che l’attuale travagliata transizione ecologica e, nello specifico, la nuova Pac per l’ortofrutticoltura, ormai in arrivo, possano contare sul pieno supporto politico governativo e su un maggiore coordinamento centrale e regionale da sempre auspicati.