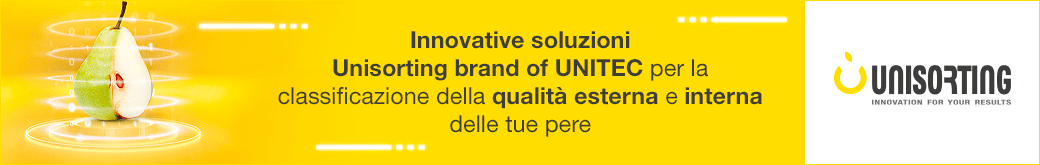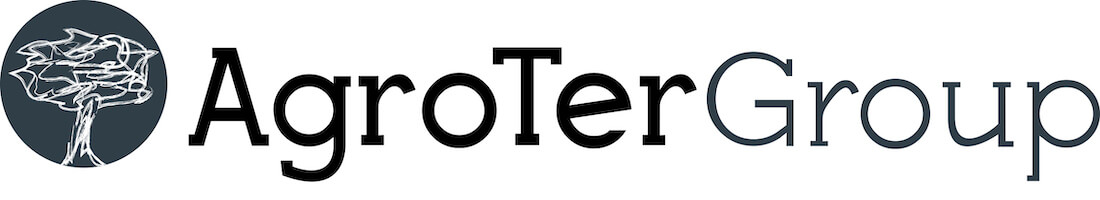Attualità
Frutti antichi, un patrimonio da recuperare
Grande contributo ad arricchire la biodiversità

Considerati varietà minori, troppo spesso i frutti antichi sono dimenticati, quando invece rappresentano una lunga storia, oltre ad un gusto sorprendente e un fattore fondamentale di biodiversità. Stiamo parlando di corbezzoli (nella foto di apertura), sorbole, pesche isontine, pere mandorline, giuggiole, arance stacce, mirabolani, biricoccole, pompia e tanti altri. Ognuno è tipico di una regione italiana e raramente si trovano nei mercatini a km zero o fiere specializzate. Ma forse varrebbe la pena recuperare questo patrimonio, considerato che – come specifica la testata thegoodintown.it - potrebbero contribuire a proteggerci da diverse malattie grazie a un vastissimo patrimonio genetico che favorisce la biodiversità e mette a disposizione tanti micronutrienti di cui conosciamo solo in parte gli effetti.
Se questi frutti antichi rischiano di scomparire non essendo interessanti per il mercato, ci sono piccoli produttori locali che hanno iniziato a curare queste nicchie, a volte anche con il sostegno dei Presidi Slow Food.
È il caso della Pera Sinora della Valle del Sinni (Basilicata) che è stata sacrificata dal mercato, considerata la domanda di varietà sempre più resistenti da parte della Gdo. La stessa sorte è toccata all’albicocca Bulida (coltivata in Valle D’Aosta e Spagna) che, pur avendo una pianta molto robusta, si caratterizza per i suoi frutti che deperiscono in breve tempo dopo la raccolta.
Alcuni frutti antichi sono invece stati eliminati dai trend commerciali perché non gradevoli alla vista: stiamo parlando della susina Gabbaladro, originaria della Puglia: per questo frutto, il colore della buccia rimane verde anche quando è matura, non invogliando particolarmente all’assaggio.
Altro motivo di ‘isolamento’ dal mercato è la produttività circoscritta a un territorio o a un microclima, ovvero tutto il contrario delle coltivazioni più specializzate: è il caso della Pesca isontina che cresce nella Valle del fiume Isonzo in Friuli Venezia Giulia.
Ma ci sono anche casi di frutti antichi più ‘fortunati’, perché riscoperti con successo dal mercato, come la mela Annurca. Questo frutto è prodotto da circa 2mila anni secondo precise tecniche di coltivazione che hanno permesso di generare codici genetici robustissimi e piante resistenti ai patogeni.
Tra gli agrumi, è stato recuperato il frutto della ‘pompia’ originario della Sardegna nord-orientale. Qui alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, a Siniscola si è deciso di impiantare una coltivazione estensiva di pompìa, per un progetto di agricoltura sociale che coinvolge il Comune di Siniscola e il CIM. Dal 2004 è un Presidio Slow Food.
Un caso ancora più particolare è rappresentato dalle banane. Tutte quelle che compriamo oggi “sono cloni, bacche geneticamente identiche e e prive di semi, e tutte sono della stessa varietà: la Cavendish, che oggi rischia di scomparire. In mancanza di diversità genica la varietà può diventare estremamente vulnerabile e sensibile. Se intaccata da qualche agente patogeno potrebbe persino estinguersi, come già successo negli anni Cinquanta con la varietà Gros Michel (nome ufficiale Musa acuminata Colla), sterminata dalla 'malattia di Panama' “. In particolare, il “problema” per le banane Cavendish è rappresentato dal fungo Fusarium oxysporum, che ha già iniziato a colpire le coltivazioni. Un caso, quello delle banane, da cui si capisce l’importanza di investire sulle varietà, recuperando anche quelle che stanno scomparendo dal mercato.
La standardizzazione dei frutti presenti sul mercato e le loro modalità di selezione sempre più restrittive contribuiscono a rendere fragile il sistema alimentare e ad aumentare gli attacchi di parassiti e patogeni, con danni sia a livello produttivo che economico, quando non addirittura alla diponibilità di cibo.
Riprendere e sostenere le produzioni locali a rischio di estinzione significa praticare biodiverisità e, al contempo, creare un’occasione economica per i piccoli produttori, contribuendo all’arricchimento alimentare e culturale dei singoli territori. (am)
Clicca qui per iscriverti alla Newsletter quotidiana di IFN