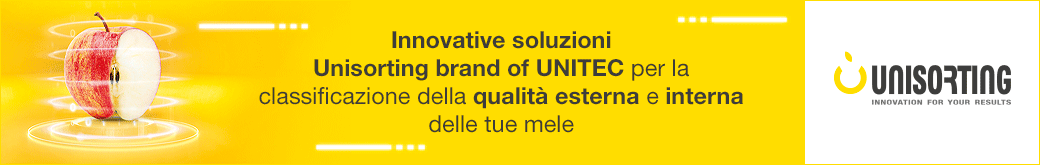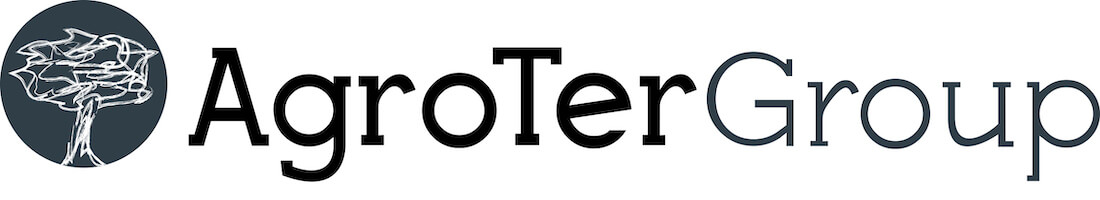Il meglio di IFN
Produttori disarmati, patogeni più forti: il suicidio assistito dell’agricoltura europea
La richiesta della moratoria sui fitofarmaci per 5 anni è un primo passo, ma occorre accelerare, su tutti i fronti

Sono passati quasi due mesi dalla nostra inchiesta sui fitofarmaci (clicca qui per approfondire) e sulla necessità di un nuovo approccio alla loro revoca (clicca qui per approfondire), un tema cruciale che – numeri alla mano – ha messo nero su bianco la portata del fenomeno: in Italia, negli ultimi cinquant’anni, è stato revocato il 75% delle sostanze attive e l’80% degli agrofarmaci. Un colpo durissimo per i produttori, sempre più in difficoltà nella difesa delle proprie colture.
Cosa è successo da allora? Da più parti si è levato un coro di proteste, ma questa non è certo una novità. Da tempo, infatti, le associazioni di categoria denunciano la deriva in atto, seppur con livelli di convinzione differenti. Tuttavia, dal nostro punto di vista un risultato è stato raggiunto: il dibattito si è finalmente acceso e, soprattutto, ora si basa su dati concreti. Non è un dettaglio da poco, perché solo partendo da numeri oggettivi si può incidere realmente nelle strategie comunitarie.
Non a caso, sono emerse anche proposte concrete. Una su tutte: la richiesta di una moratoria di cinque anni sulle attuali revoche, avanzata da Fedagripesca Confcooperative per voce del presidente Raffaele Drei. Confcooperative, a tutti gli effetti, si è distinta per la sua posizione netta, ribadita in più occasioni dai suoi dirigenti. Lo stesso Davide Vernocchi, presidente del settore ortofrutticolo, ha dichiarato proprio su queste colonne: “Per ogni molecola che ci tolgono, rischiamo di perdere una coltura” (clicca qui per approfondire). E a Berlino, durante Fruit Logistica, Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, ha rincarato la dose: “Rischiamo di non tornare più qui. Non perché Berlino non ci piaccia, ma perché non avremo più nulla da vendere”.
Non è un caso che Drei, Vernocchi e Gardini siano tutti frutticoltori dell’Emilia-Romagna, e quindi conoscono perfettamente le dinamiche che si vivono in campo, che non migliorano. Anzi, continuano a peggiorare perché nel frattempo la scure sulle sostanze attive non si ferma e ogni stagione diventa più difficile proteggere le colture.
L’ultimo caso è quello dell’acetamiprid, principio attivo chiave nella lotta contro la cimice asiatica, che da quest’anno subisce forti restrizioni.
I tecnici confermano: l’acetamiprid, inserito in una strategia di lotta integrata, era prezioso perché selettivo — efficace contro la cimice, ma innocuo per gli insetti utili. Al suo posto, ora, saranno utilizzati piretroidi, anche ammesse in biologico, che però hanno un effetto ad ampio spettro, colpendo indiscriminatamente anche i predatori naturali come l’antocoride, prezioso alleato nel controllo della Psilla. Peccato che, proprio contro la Psilla, sia stata recentemente fortemente limitata anche l’abamectina, altro strumento efficace.

Come affrontare questa situazione? Le risposte raccolte nei campi sono, a dir poco, colorite e ve le risparmiamo. Il concetto di fondo, però, è sempre lo stesso: eliminare i fitofarmaci senza proporre valide alternative è puro masochismo. Non solo: meno sostanze attive significa anche maggiore rischio di resistenze da parte dei patogeni, una dinamica che ormai è scientificamente dimostrata. La sensazione è che dietro alle revoche non ci sia un approccio tecnico, ma piuttosto una visione ideologica.
Tuttavia, la ciliegina sulla torta riguarda il concetto di reciprocità: questo sconosciuto verrebbe da esclamare, visto che proseguono le segnalazioni di prodotto ortofrutticoli provenienti da Paesi terzi che non rispettano le normative comunitarie sui prodotti fitosanitari. A dimostrarlo sono i numeri: solo nei primi due mesi del 2025, il sistema di allerta europeo RASFF ha segnalato 17 partite di agrumi irregolari (9 a gennaio e 8 a febbraio), principalmente da Egitto e Turchia, colpevoli di contenere residui di principi attivi vietati in Europa o con livelli oltre i limiti consentiti.
Le sostanze incriminate — dimetoato, clorprofam, fentoato e profenofos — sono tutte vietate per i produttori europei. Eppure, i prodotti extra UE continuano a entrare, a patto di rispettare i limiti di residuo. Il paradosso è evidente: ci autocostruiamo barriere, lasciando libero accesso a chi non segue le stesse regole. Un caso da manuale di concorrenza sleale. Ma, come sappiamo, nelle relazioni internazionali, vige il principio del compromesso e, se dobbiamo necessariamente esportare in nostri manufatti di qualità nei paese produttori di ortofrutta, come possiamo pensare che sul piatto della bilancia non vengano messe le loro derrate agricole come merce di scambio? Di più, come possiamo credere che saranno in grado di far evolvere le loro agricolture verso i nostri modelli ambientalmente virtuosi in poco tempo? E qui entra in scena il concetto di utopia, che vi risparmio.
La logica imporrebbe che, se una sostanza è vietata in Europa, deve essere vietata anche nei Paesi da cui importiamo. Invece accade il contrario: è come se applicassimo dazi doganali – che adesso vanno tanto di moda – ai nostri stessi produttori. Un’assurdità in teoria ma che farà parte del pacchetto negoziale e che ci dovrebbe suggerire di provare a cercare una nuova posizione più morbida e più gestibile, dati gli interessi in gioco. Quindi, un avvicinamento progressivo degli standard che darebbe modo anche a noi di utilizzare molecole utili fino a quando non saremo in grado di sostituirle. Se no, come scriveva il nostro Direttore (clicca qui per approfondire), usciremo da questa situazione becchi e bastonati.
Con il cambio ai vertici della Commissione Europea, qualcosa sembra muoversi: dalle dichiarazioni del commissario Hansen (clicca qui per approfondire) traspare la volontà di rivedere alcune scelte troppo ideologiche legate al Green Deal. Ma il tempo stringe: la primavera è alle porte e i patogeni non aspettano. (gc)