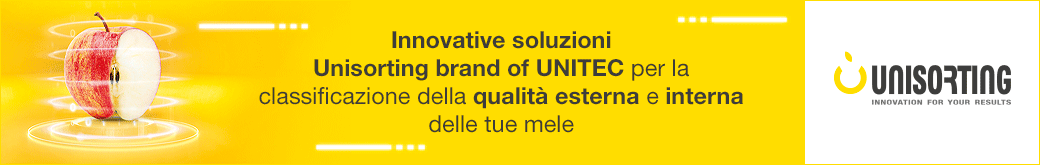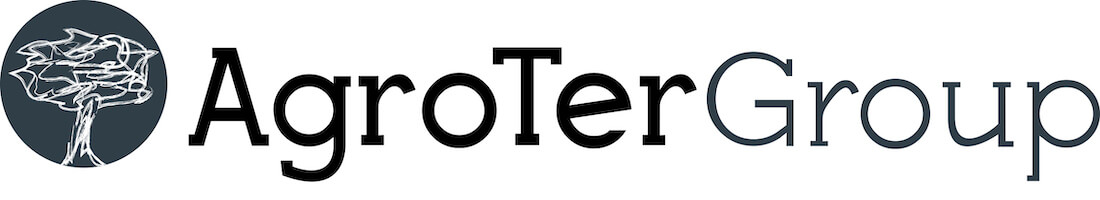Dal campo
Fertilizzanti, rincari senza tregua: +6% nel primo trimestre 2025
Tra gas, fosfati e urea, l’Europa alla ricerca di alternative. Ma il tempo stringe

Dopo una breve fase di apparente stabilizzazione, i prezzi dei fertilizzanti sono tornati a salire. Nel primo trimestre del 2025, secondo quanto riportato dal Commodity Markets Outlook della Banca Mondiale, il costo degli input chimici per l’agricoltura è aumentato del 6%, con una previsione di chiusura d’anno a +7% rispetto al 2024.
Lo segnala il mensile di Confagricoltura Mondo Agricolo, nell’edizione di giugno, in un approfondito articolo a firma di Francesco Bellizzi, che analizza l’evoluzione dei prezzi e le variabili geopolitiche che influenzano il settore.
La prospettiva di una stabilizzazione, attesa nel 2026 grazie all’incremento della produzione annunciata in Medio Oriente e Asia, è oggi messa in discussione dall’evoluzione del conflitto tra Israele e Iran, che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri. L’analisi della Banca Mondiale, infatti, risale a pochi giorni prima dell’inasprimento delle ostilità.
Nel dettaglio, il prezzo dell’azoto, e quindi dell’urea, è aumentato del 12% nei primi tre mesi del 2025, raggiungendo quasi il +20% su base annua. A spingere i rincari è l’aumento della domanda da parte di India e Brasile, a fronte di una produzione rallentata dalla stretta all’export imposta dalla Cina, che ha tagliato del 90% le esportazioni di urea. Il risultato è un forte squilibrio tra domanda e offerta, con l’indice di accessibilità (rapporto tra prezzo dei fertilizzanti e prodotti alimentari) che ha toccato a marzo il livello più alto degli ultimi 16 mesi.
Anche il fosfato di ammonio (DAP) segna un incremento del 5% nel primo trimestre, e si prevede chiuda l’anno a +6%. Le cause principali? I dazi sulle importazioni dalla Russia e le limitazioni cinesi all’export di fosfati, dovute alla priorità interna data alla produzione di batterie. Le conseguenze si avvertono soprattutto in Europa, che ha iniziato a sostituire l’import da Mosca e Pechino con forniture da Arabia Saudita, Marocco e Stati Uniti – soluzioni più costose e logisticamente più complesse.
In aumento anche il prezzo del cloruro di potassio (MOP): +12% nel primo trimestre, pari a un +8% annuo. La disponibilità, per ora, è garantita anche grazie all’export russo, cresciuto del 70% nel 2024 e tuttora non soggetto a sanzioni. Un paradosso: mentre l’Ue rafforza le sanzioni contro Mosca, l’import di fertilizzanti russi continua ad aumentare, toccando a marzo i 206 milioni di euro, il 15% in più rispetto allo stesso mese del 2024. Oggi, il 26% dell’import di fertilizzanti dell’UE proviene ancora dalla Russia.
Ma la situazione è destinata a cambiare. A metà maggio, la Commissione Commercio del Parlamento europeo ha approvato un nuovo pacchetto di dazi: entro il 2028, i fertilizzanti russi saranno soggetti a una tariffa di 430 euro per tonnellata. Una misura che rischia di innescare ritorsioni: Mosca potrebbe colpire le sue importazioni dall’Ue (12,4 miliardi di euro), in particolare nei settori dei macchinari e dei farmaci. Inoltre, è probabile che Russia e Bielorussia reindirizzino le loro esportazioni verso mercati alternativi come Brasile e India.
Secondo l’OCSE, i nuovi dazi comporteranno un aumento stimato dell’1,2% per i costi degli input agricoli e dello 0,4% sui prezzi alimentari. La BCE, in linea con queste stime, prevede un’inflazione al consumo del +2,1%. Tra i Paesi più colpiti ci saranno Germania e Polonia, mentre la Francia, che dipende solo per il 3% dai fertilizzanti russi, si trova in una posizione meno vulnerabile. Anche Italia e Slovenia restano esposte.
Il problema è strutturale. Nel 2024, la produzione interna europea di fertilizzanti azotati ha raggiunto solo 8,7 milioni di tonnellate, a fronte di un fabbisogno di 24,9 milioni. I motivi: impianti poco efficienti, calo dell’import di gas naturale russo e aumento dei costi energetici.
L’Ue punta quindi a diversificare le forniture, intensificando i rapporti con Paesi come Marocco, Norvegia, Egitto, Qatar e Canada. Ma la strada è tutt’altro che semplice: l’Egitto già esporta verso l’Europa il 60% della sua produzione di fertilizzanti, mentre il Marocco è forte sui fosfati ma meno competitivo su urea e nitrato d’ammonio.
A complicare il quadro, lo scontro tra Israele e Iran ha messo in crisi anche la produzione in Paesi-chiave come Egitto e Qatar, dove diverse attività industriali ad alto consumo energetico – come quelle legate ai fertilizzanti – sono state temporaneamente sospese. Il Canada, sebbene affidabile, resta penalizzato dai costi logistici elevati.
Conclusione: l’Europa si trova in una fase critica, stretta tra la necessità di indipendenza energetica e agricola e una realtà geopolitica sempre più incerta. I fertilizzanti diventano così un indicatore strategico non solo per l’agricoltura, ma per l’intera tenuta economica e politica del continente. (bf)